
Malcontento
Le parole che mi piovono dalla Nuvola di Fuksas sono sempre le più belle, che mi ci trovi immersa per la fiera dei libri o per la seconda dose del vaccino AstraZeneca.
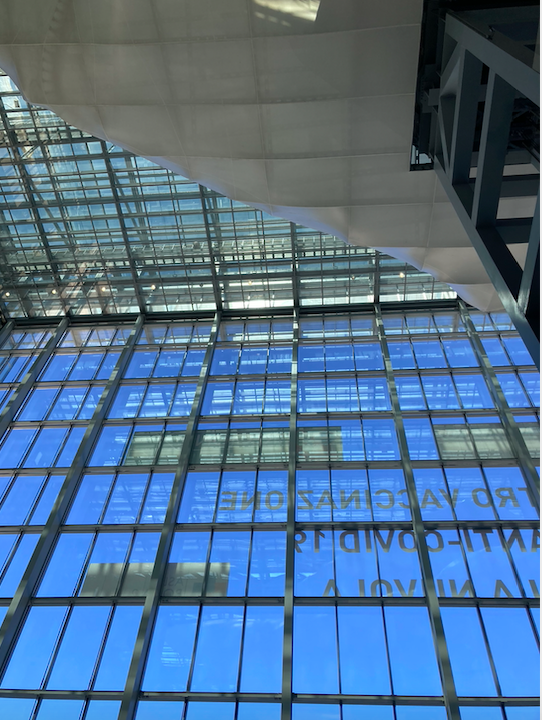
Continuo a lasciarmi trasportare dall’onda della religiosità e mi arriva in punta di penna la parola Malcontento. Me la dona una giovane donna, medico, ragazza dagli occhi chiari chiari, all’accettazione. Anche il mio amico medico Luigi ha gli stessi occhi, penso tra me e me, mentre la ragazza mi chiede, ‘quale braccio?’ È pronta a segnarlo sul modulo e io rimango interdetta dalla possibilità di decidere. ‘Credevo fosse prima dose un braccio seconda dose l’altro, ora così su due piedi non so cosa scegliere’. ‘Decido io allora per lei, il sinistro’. È lo stesso dell’altra volta e la sensazione che provo è di uno sbandamento dovuto a un’onda improvvisa e inaspettata che potrebbe causare un sinistro.

Mi sollevo, poi mi risiedo, ‘non potrei cambiare idea?’ Lei mi guarda con quegli occhi mare calmo, ‘no, ormai ho deciso io, poi se le farà molto male il braccio potrà prendersela con me’. Le sorrido e penso, cavoli quanta empatia. Sono stata seduta per qualche minuto appena, il tempo di compilare un modulo e lei mi ha colta, precisa, puntuale, ha abbracciato la mia indecisione e se ne è presa cura. Un po’ come Luigi, oncologo, che tempo fa mi raccontava del suo rapporto con i pazienti e di come sia importante sostenere il loro stato mentale, non solo fisico, trasmettere loro speranza. Le dico, ‘regalami la tua parola’. Ci pensa un attimo e mi lancia Malcontento. ‘Capisco’, le dico. ‘Non è una cosa mia’, si spiega ‘è più per tutto questo’ e indica la struttura, l’organizzazione. Le rispondo, vero, ma sai che ti dico? Guardati il film su Roberto Baggio, ‘Il divin codino’, su Netflix. L’hai già visto? Mi fa, no, curiosa. È un film sulla speranza, intesa come quella spinta, quella tensione, che ci mantiene aperti alla religiosità che è in noi. Sono buddista, le dico, ma anche fisica, e quindi non so quello che dico, lo intuisco e sperimento, ed è quello che mi fa stare bene quando attraverso le onde del Malcontento.

Che parola bellissima, penso poi, uscendo dalla nuvola, una parola ondosa, ondivaga, ondeggiante, e il mio cervello si àncora tra quelle lettere, le spezzetta, le ricompone. E penso al senso che mi appare, quello di rendere il male contento, cioè nutrire il male, il sentimento negativo, lamentarsi, o crogiolarsi in quel posto. Una parola che associo alla ‘voluptas dolendi’ del Petrarca. Nel Canzoniere, il poeta dell’amore si concentra sul suo stato d’animo interiore, esprimendo la sofferenza che prova per amore di Laura: ‘dolendi voluptas quaedam’.
Solo e pensoso i più deserti campi
vo mesurando a passi tardi e lenti,
e gli occhi porto per fuggire intenti
ove vestigio uman l’arena stampi.
Altro schermo non trovo che mi scampi
dal manifesto accorger de le genti,
perché negli atti d’allegrezza spenti
di fuor si legge com’io dentro avampi:
si ch’io mi credo omai che monti e piagge
e fiumi e selve sappian di che tempre
sia la mia vita, ch’è celata altrui.
Ma pur sì aspre vie né sì selvagge
cercar non so ch’Amor non venga sempre
ragionando con meco, ed io con lui.
Francesco Petrarca, Canzoniere XXXV
C’è piacere in questo star male per amore, un compiacimento nel male, in quell’oscurità che ci rende ciechi, ci impedisce di vedere oltre il limite, navigando tra le onde nel malcontento. Poi mi dico, e se fosse il contrario? Se invertissimo l’onda di questa parola e pensassimo a come inserire la contentezza, la gioia nel male, nell’ombra? Quale potrebbe essere la strada? E mi viene in mente l’idea buddista di illuminazione, il concetto per cui anche nella sofferenza, nel male, esiste la luce, la buddità, la possibilità di sperimentare la gioia del Budda.
È sempre più spesso così nella mia vita, mi dico, e ripenso a una serata magica che ho vissuto, mentre sorgeva la superluna, poche ore prima del vaccino. Ero seduta su un prato del parco di Montemario, computer sulle ginocchia, un’amica al mio fianco che attraversa un duro momento, dallo schermo un gruppo di persone che si confrontavano sul tema della speranza. E io pensavo a Leopardi, alla speranza come la intendeva lui, quella tensione che spinge a oltrepassare il limite, il confine.
Dallo Zibaldone: “La speranza non abbandona mai l’uomo in quanto alla natura. Bensì in quanto alla ragione”. Anche nelle maggiori disgrazie l’uomo mantiene sempre “una scintilla, una goccia di lei”. D’altra parte: “È meglio del piacere, contenendo quell’indefinito, che la realtà non può contenere”. Non è forse vero che “La speranza di un piccolo bene, è un piacere assolutamente maggiore del possesso di un bene grande già provato”?. E infine: “Chi nulla spera, non sente, e non compatisce”.
Dialogavamo, io la mia amica e diverse persone connesse e in cammino, mentre il buio calava su di noi e la luna diventava sempre più grande e rossa. Parlavamo di pratica buddista della Soka Gakkai, del maestro Daisaku Ikeda, di come la recitazione di una frase, ‘Nam Myoho Renge Kyo’, ci aiuti a sintonizzarci con quel senso di speranza, per trasformare il malcontento in gioia, il veleno in medicina, l’inverno in primavera.

Il parco si faceva buio e ripensavo al percorso che avevo fatto per arrivare dall’ingresso, vedevo le panchine rotte, l’erba alta, l’incuria di certi luoghi bellissimi a Roma, eppure si è alzata la luna e sono apparse le lucciole, luminose, tante, mai viste prima le lucciole a Roma. Ci siamo incamminate per uscire dal parco e mi sono accorta di un ragazzo nell’ombra intento scattare foto, con il suo treppiedi. Stava lì, concentrato, solo, pronto a cogliere la bellezza. Ci siamo scambiati un saluto e gli ho chiesto se era fotografo di professione. Lo è e mi lascia il suo nome Emanuele Serraino, e per me, anche se non l’ho chiesto, la sua parola è Luna.

Sono giorni complessi, dolorosi, assurdi, notizie strazianti da ogni direzione, eppure siamo qui, appaiono le lucciole, una parola che d’ora in poi sarà la parola della mia amica Giulia per me. E mentre ci sosteniamo a vicenda, nelle onde alte, c’è qualcuno che dedica la sua vita a fotografare la Luna. E in lui ho percepito la poesia di Leopardi, nel suo parlare alla luna dal Canto Notturno.
Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai,
Silenziosa luna?
Sorgi la sera, e vai,
Contemplando i deserti; indi ti posi.
Ancor non sei tu paga
Di riandare i sempiterni calli?
Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga
Di mirar queste valli?
Somiglia alla tua vita
La vita del pastore.
Sorge in sul primo albore
Move la greggia oltre pel campo, e vede
Greggi, fontane ed erbe;
Poi stanco si riposa in su la sera:
Altro mai non ispera.
Dimmi, o luna: a che vale
Al pastor la sua vita,
La vostra vita a voi? dimmi: ove tende
Questo vagar mio breve,
Il tuo corso immortale?
Vecchierel bianco, infermo,
Mezzo vestito e scalzo,
Con gravissimo fascio in su le spalle,
Per montagna e per valle,
Per sassi acuti, ed alta rena, e fratte,
Al vento, alla tempesta, e quando avvampa
L’ora, e quando poi gela,
Corre via, corre, anela,
Varca torrenti e stagni,
Cade, risorge, e più e più s’affretta,
Senza posa o ristoro,
Lacero, sanguinoso; infin ch’arriva
Colà dove la via
E dove il tanto affaticar fu volto:
Abisso orrido, immenso,
Ov’ei precipitando, il tutto obblia.
Vergine luna, tale
È la vita mortale.
Nasce l’uomo a fatica,
Ed è rischio di morte il nascimento.
Prova pena e tormento
Per prima cosa; e in sul principio stesso
La madre e il genitore
Il prende a consolar dell’esser nato.
Poi che crescendo viene,
L’uno e l’altro il sostiene, e via pur sempre
Con atti e con parole
Studiasi fargli core,
E consolarlo dell’umano stato:
Altro ufficio più grato
Non si fa da parenti alla lor prole.
Ma perché dare al sole,
Perché reggere in vita
Chi poi di quella consolar convenga?
Se la vita è sventura,
Perché da noi si dura?
Intatta luna, tale
È lo stato mortale.
Ma tu mortal non sei,
E forse del mio dir poco ti cale.
Pur tu, solinga, eterna peregrina,
Che sì pensosa sei, tu forse intendi,
Questo viver terreno,
Il patir nostro, il sospirar, che sia;
Che sia questo morir, questo supremo
Scolorar del sembiante,
E perir dalla terra, e venir meno
Ad ogni usata, amante compagnia.
E tu certo comprendi
Il perché delle cose, e vedi il frutto
Del mattin, della sera,
Del tacito, infinito andar del tempo.
Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore
Rida la primavera,
A chi giovi l’ardore, e che procacci
Il verno co’ suoi ghiacci.
Mille cose sai tu, mille discopri,
Che son celate al semplice pastore.
Spesso quand’io ti miro
Star così muta in sul deserto piano,
Che, in suo giro lontano, al ciel confina;
Ovver con la mia greggia
Seguirmi viaggiando a mano a mano;
E quando miro in cielo arder le stelle;
Dico fra me pensando:
A che tante facelle?
Che fa l’aria infinita, e quel profondo
Infinito seren? che vuol dir questa
Solitudine immensa? ed io che sono?
Così meco ragiono: e della stanza
Smisurata e superba,
E dell’innumerabile famiglia;
Poi di tanto adoprar, di tanti moti
D’ogni celeste, ogni terrena cosa,
Girando senza posa,
Per tornar sempre là donde son mosse;
Uso alcuno, alcun frutto
Indovinar non so. Ma tu per certo,
Giovinetta immortal, conosci il tutto.
Questo io conosco e sento,
Che degli eterni giri,
Che dell’esser mio frale,
Qualche bene o contento
Avrà fors’altri; a me la vita è male.
O greggia mia che posi, oh te beata,
Che la miseria tua, credo, non sai!
Quanta invidia ti porto!
Non sol perché d’affanno
Quasi libera vai;
Ch’ogni stento, ogni danno,
Ogni estremo timor subito scordi;
Ma più perché giammai tedio non provi.
Quando tu siedi all’ombra, sovra l’erbe,
Tu se’ queta e contenta;
E gran parte dell’anno
Senza noia consumi in quello stato.
Ed io pur seggo sovra l’erbe, all’ombra,
E un fastidio m’ingombra
La mente, ed uno spron quasi mi punge
Sì che, sedendo, più che mai son lunge
Da trovar pace o loco.
E pur nulla non bramo,
E non ho fino a qui cagion di pianto.
Quel che tu goda o quanto,
Non so già dir; ma fortunata sei.
Ed io godo ancor poco,
O greggia mia, né di ciò sol mi lagno.
Se tu parlar sapessi, io chiederei:
Dimmi: perché giacendo
A bell’agio, ozioso,
S’appaga ogni animale;
Me, s’io giaccio in riposo, il tedio assale?
Forse s’avess’io l’ale
Da volar su le nubi,
E noverar le stelle ad una ad una,
O come il tuono errar di giogo in giogo,
Più felice sarei, dolce mia greggia,
Più felice sarei, candida luna.
O forse erra dal vero,
Mirando all’altrui sorte, il mio pensiero:
Forse in qual forma, in quale
Stato che sia, dentro covile o cuna,
È funesto a chi nasce il dì natale.
