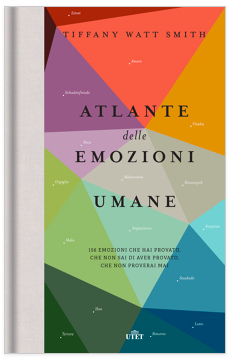
Kaukokaipuu
Ci sono parole ancora sconosciute, parole che non abbiamo incontrato, eppure le cerchiamo, faticando a capire noi stessi, a farci comprendere, a decifrare chi siamo e chi è l’altro da noi. Non riusciamo a esprimere quello che sentiamo, non troviamo le parole giuste per tradurre fedelmente il nostro mondo interno, per farci capire, ma prima di tutto riuscire a capire noi stessi. Ci affidiamo in alcuni casi alle parole altrui, quelle che ci vengono imposte dai rapporti che ci formano nell’infanzia, o che ci vengono offerte, regalate, in quella relazione speciale che è l’amicizia. In ogni caso si tratta di qualcuno che prova a darci le sue parole, quelle che considera giuste, reali. Ma reali per chi? E di quale realtà sono espressione e codificazione?

Ho rivisto tre amici che non incontravo da anni. Negli occhi non percepivo l’oceano temporale che ci separava da chi eravamo un tempo, in quel passato che ci aveva fatti incontrare, compagni di banco e di studi. Ora come allora abbiamo cognomi che iniziano per la lettera C e per questo motivo del tutto casuale ci eravamo conosciuti in facoltà, primo anno di Fisica alla Sapienza di Roma, nel canale A-K, quell’insieme particolare che raggruppava le nuove matricole con cognomi dalla A alla K. Ho rivisto i tre amici sulla soglia della stessa casa che frequentavamo decenni fa. Quella soglia dove ci si fermava a parlare, per minuti, a volte per ore, senza volersi davvero separare, nessuno pronto a chiudere la porta, a osservare come un sipario calava sulle nostre serate, una barriera si interponeva, separando, dividendo, lasciando quel qualcosa in sospeso. In quel gruppo di entusiasti per la scienza, c’era un amico speciale, il cui cognome inizia con la lettera K. E dal suo cognome, dalla sua accentuata difficoltà a salutare, era nato un nostro termine, coniato dopo anni di chiacchierate sulla soglia, incapaci al distacco. Kovacs era maestro dello stare su quel confine, né da una parte né dall’altra. Era colui che non si riusciva a salutare, che non riusciva ad accomiatarsi. E cosi, alla fine di serate che non sono forse mai finite in qualche universo parallelo, sostavamo con lui sulla soglia, intercalando nuovi temi e nuove riflessioni, battute e discorsi interminabili, a qualche timido “arrivederci” poco convinto, o “si è fatta una signora ora”, quasi fieri della capacità che avevamo di procrastinare il distacco a oltranza.

Eravamo tutti ammalati di qualcosa che non sapevamo esprimere se non con un termine inventato, la ‘kovacsite’ appunto, quella condizione cronica, acuita dalla presenza di Kovacs, che ci rendeva incapaci di oltrepassare le soglie del commiato, di chiudere porte lasciando qualcosa fuori, qualcuno dentro, o viceversa. Riflettevo su questo qualche sera fa, mentre sedevo a conversare con amici ormai quasi guariti da quel contagio. Li guardavo e mi vedevo, i nostri anni addosso, le tante porte chiuse, le innumerevoli soglie attraversate senza troppi rimpianti. Le voci e gli sguardi provavano a ricordarsi un tempo che non è più. Ma i nostri corpi no, ne portano i segni, le ferite, le cicatrici sbiancate e guarite, ma non del tutto scomparse. Ci ricordano il percorso fatto, lo spazio che ci separa da chi eravamo e i tentativi di contrastare quella separazione. Come quando, nel momento dei saluti di oggi, con la fretta di allontanare il rimpianto per qualcosa che non potrà tornare, ci siamo ritrovati sulla stessa soglia. E riconoscerla è stato un lenitivo, una cura, una medicina. La ‘kovacsite’ esiste ancora, ci siamo ricordati sorridendo. Non era una prerogativa di quel tempo, di quell’essere giovani. E non è un sentimento cosi strano, peculiarità delle amicizie intrecciate allora. Noi avevamo coniato quella parola per descriverlo. Ma ne esistono altre, proprio come la nostra. Una tribù che vive sulle montagne della Papua Nuova Guinea, la popolazione Baining, si riferisce alla malinconia lasciata dalla partenza di un amico che si è ospitato, con la parola ‘‘awumbuk’, parola che termina con la lettera K. Dopo il distacco, per assorbire la foschia che l’ospite lascia dietro di sé, gli indigeni Baining dispongono ciotole d’acqua negli angoli della casa.
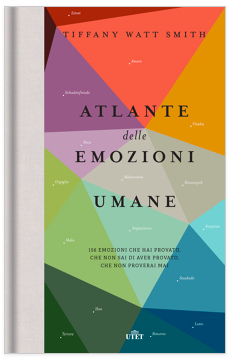
Questa e altre parole sono narrate nel libro intitolato “Atlante delle emozioni” di Tiffany Watt Smith (Utet Editore). Una per tutte mi risuona alla fine di un anno che volta pagina su un ventennio. Comincia per K, una lettera soglia, nel nostro alfabeto occidentale, uno spartiacque di un sistema binario, da una parte l’insieme dalla A alla K, dall’altra quello dalla L alla Z. La K è un punto medio tra chi va avanti e chi torna indietro. Un punto dove la differenza non esiste, la freccia del tempo non è ancora diretta, in un senso o nell’altro.
‘Kaukokaipuu’ è una parola finlandese. Significa quel sentimento di mancanza, di nostalgia, di rimpianto, quel desiderio di essere in un luogo diverso, diverso da quello in cui siamo e in cui forse non saremo mai. Assomiglia forse al sentimento che proviamo quando un ospite ci saluta e lascia la nostra casa. E noi rimaniamo fermi, la sua presenza ancora nell’aria che respiriamo. Un attimo prima eravamo insieme e ora siamo soli e malinconici, il vuoto lasciato dalla presenza diventata assenza. Ed espressa dagli indigeni di Papua con la parola di cui K è la fine, ‘awumbuk’. È un senso di mancanza che assomiglia al rimpianto per i luoghi non ancora visitati, i posti che non conosciamo, che ci attraggono, pur essendo forse irraggiungibili. Non è forse questo che ci spinge avanti, a conoscere, a capire, a non perdere di vista il bisogno di tradurre il nostro canale A-K in quello dell’altro L-Z?
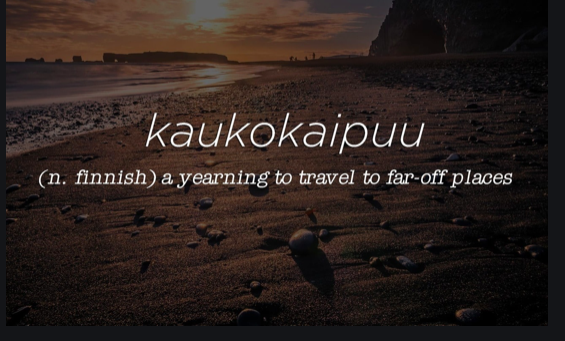
È questo che ci rende umani, la tensione a contrastare la separatezza, questa capacita di provare un sentimento di mancanza per qualcosa che non abbiamo che forse non raggiungeremo mai. Eppure tentiamo di arrivarci, viaggiamo muovendo un passo dopo l’altro, guidati dal sentimento di “kaukokaipuu’. Alcune rare volte ci è concesso di fermarci sulla soglia. Come quando un anno finisce. Ne inizia uno nuovo. Ma cosa cambia davvero? Cosa ci lasciamo alle spalle? Cosa ci aspetta? Ho festeggiato questa fine di un ventennio con un senso nuovo di gratitudine per le tante parole che hanno formato la mia vita fino ad oggi, ognuna legata alle persone che ho potuto scegliere di incontrare nel mio viaggio, insieme anche solo per qualche passo. Pensavo al piccolo magazzino che è diventato questo blog, un anno compiuto da poche settimane. Ricordavo, scivolando nel 2020, la candelina, una ma tangibile, che ho spento assieme a tanti amici di carta, di penna e di carne e ossa, nella Nuvola di Fuksas, durante Plpl2019, festeggiando il luogo dove tutto è cominciato. Perché è stato lì, un anno fa, che il mio ombrello si è capovolto e ha cominciato a raccogliere le gocce di una pioggia di parole, a collegarle con le persone che scrivono, che leggono, con i libri, con le case editrici, più o meno indipendenti.

Ora è gennaio inoltrato. Sono ancora sulla soglia, incapace di andare avanti, felice di riconoscere che un mio progetto c’è, continua, vuole crescere, desiderosa di rimanere scrivente, di comunicare attraverso la scrittura le relazioni che scopro tra le parole che acchiappo, e al contempo invasa da una strana nostalgia per quello che sarà, che diventerà. Wordfetcher è una scatola aperta, pronta a contenere o ad essere svuotata, mi ha riportata a scrivere come ho sempre voluto fare. Proprio come la vita, nell’eterna alternanza tra la parola ‘kovacsite’, inventata da un gruppetto di fisici perduti, e la parola ‘kaukokaipuu’, lo stimolo inesauribile a diventare quello che già siamo.

Che bella parola, ora capisco perché hai detto che mi ci sarei ritrovato. Ti voglio bene mamma