
Aliene
Due figure di donne si stagliano contro un cielo azzurrissimo, sono di spalle, vestite di colori accesi, insieme raccolgono qualcosa nell’erba, sradicano infestanti forse, chinate nell’atto della cura. In un’altra immagine si abbracciano, i volti nascosti, una nell’accogliere l’altra. Le guardo e sento di essere parte di quel paesaggio, di quel pianeta altro.

“Girls from another planet” è il titolo di un progetto della fotografa Francesca Tilio, originaria delle Marche, e di una mostra allestita dalla Galleria Mo.C.A di Cinzia Bonamoneta a Piazza degli Zingari, Rione Monti, fino al 20 Ottobre. All’inaugurazione, invitata dalla curatrice Francesca Macera, ho catturato la parola Aliene. E con essa una serie di suggestioni che continuano a germogliare tra i miei pensieri, estirpando le erbacce appunto, e lasciando emergere il senso dell’essere donna, qui e ora.
Donna, prima che figlia, prima che madre, prima che moglie, prima che amante, prima che lavoratrice, prima che accudente, nel senso di colei che si prende cura.
Chi sono io come donna?

In risposta, la parola Aliene riecheggia nello spazio immobile di una galleria piena di gente in transito, tra poche ma essenziali fotografie. Una donna in un cielo azzurro chiarissimo mi attrae come una calamita, i lineamenti netti e precisi, eppure slavati da un velo trasparente. Più la guardo più vedo attraverso e ritrovo il mio volto, o quello dell’aliena che sono, su questo pianeta che mi ha modellata da uno stampo maschile.

Tre figure eteree, vestite di bianco e nero, si stagliano in un paesaggio terrestre eppure quasi lunare. Sono evanescenti, androgine forse, formano una trinità declinata al femminile. I corpi sono espressione di quei sentimenti che in genere traspaiono dai volti, in questo caso occultati da un velo. Su una parete della galleria, una serie di miniature rappresentano le stesse ragazze delle foto macroscopiche, in pose diverse da quelle dei quadri esposti, e private dei volti. Al loro posto uno spazio vuoto, bianco e circolare.

Mi fa pensare agli esseri di un romanzo che sto leggendo da qualche anno, lo prendo e lo poso, senza mai finirlo. Si intitola “The book of strange new things”, in italiano tradotto da Bompiani come “Il libro delle cose nuove e strane” di Michel Faber. La voce narrante è quella di un missionario terrestre in viaggio su un pianeta colonizzato dagli esseri umani. Sul pianeta vive una popolazione nativa e aliena, afflitta da una epidemia della quale non si capisce l’origine e per la quale non sembra esserci cura. Un comitato misterioso gestisce la presenza dei terrestri su questo pianeta dove gli esseri alieni non hanno volto, sono indistinguibili gli uni dagli altri. Le loro sembianze simili li fanno apparire come esseri amichevoli e in qualche modo privi di difese, desiderosi di ricevere gli insegnamenti del protagonista missionario e del libro che ha con sé, quello delle cose nuove e strane, che non è altro che la Bibbia. La storia sembra seguire lo schema tipico di altre storie di conquista da parte di un popolo che assoggetta un popolo altro.

Non so perché non riesco a finirlo. Ogni tanto mi ritorna in mente qualche immagine, mi chiedo perché l’abbia appoggiato e lo riprendo. È come se volessi rimanere sospesa nella sensazione della voce narrante, il missionario partito lasciando la sua donna sulla terra, la persona che più è capace di infondergli speranza ma che con la distanza interplanetaria diventa una voce flebile e disperata, pronta a scomparire, come sta facendo la terra, dove si susseguono guerre e disastri ecologici. I due si mandano lettere che arrivano con un ritardo dovuto alla distanza tra i pianeti. Lui invia le cronache della sua esplorazione, miste alle parole d’amore che arriveranno alla sua donna in ritardo rispetto al tempo in cui le scrive. E lo stesso accade per le risposte, dalle quali traspare la graduale perdita di fiducia e di speranza. Il protagonista non sa, mentre legge, non può sapere, se la donna che ha scritto è ancora viva. E nella sua attesa mi sono persa anche io. Così, pur non avendo terminato la lettura del romanzo, o forse proprio per questo, lo porto con me, lo vivo a volte nel mio approccio con la scrittura, che è un po’ come voler comunicare attraverso una capsula del tempo, messaggi che hanno a che fare con il mio momento, il mio spazio.
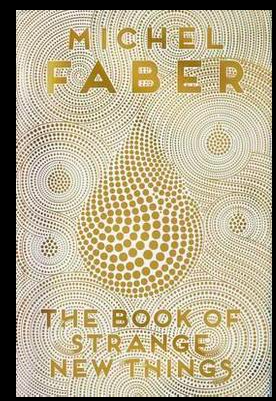
Tornando alla mostra, le ragazze fotografate nell’atto di abbracciarsi o di abbracciare l’aria, mi hanno infuso coraggio e speranza. Sono anche io una di loro, un’abitante del pianeta da dove provengono, anche io prima o poi riuscirò a riconoscermi e abbracciarmi, prendermi cura della donna che sono, senza inseguire quella che vorrei essere, senza perdermi nell’attesa di messaggi che, seppure arrivassero, sarebbero comunque parte di un tempo passato.

La stessa tensione verso la comunicazione, l’attesa di un contatto, la ricerca di sé nell’altro e dell’altro in sé, l’ho trovata nell’incredibile “Cronache marziane” (Mondadori) di Ray Bradbury, lo stesso del trattato sulla scrittura, “Lo zen e l’arte di scrivere”, del quale ho scritto riguardo alla parola Snodo. Le cronache uscirono come una serie di racconti uniti dal filo conduttore cronologico di una immaginaria colonizzazione del pianeta Marte da parte degli umani. A volte le descrizioni sono quasi oniriche: “All’alba il sole, penetrando fra gli intercolumnii, sciolse i vapori che sostenevano Ylla nel sonno. Per tutta la notte era rimasta sospesa a mezz’aria, ancorata alla morbida amaca di vapori che le pareti esalavano quando si accingeva al sonno. Per tutta la notte aveva dormito sul fiume silente, come una barca su una languida muta fiumana. Ora, con l’evaporare della nebbia, il livello dei vapori discese fino a quando Ylla fu deposta con dolcezza sulla sponda del risveglio”. Altre volte riguardano la storia degli eventi marziani e terrestri quasi fossero vere e proprie cronache giornalistiche. Altre volte ancora si spingono a riflessioni filosofiche:
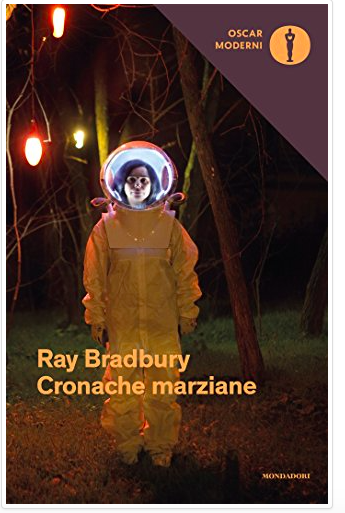
“Sapevano vivere con la natura e ci andavano d’accordo. Non hanno mai cercato di essere a tutti i costi solo uomo e niente animale, l’errore che noi abbiamo commesso dopo le scoperte di Darwin. Lo abbiamo abbracciato, con Huxley e Freud, tutti sorrisi, salvo accorgerci che Darwin e le nostre religioni non andavano d’accordo. O almeno ci è parso che non andassero d’accordo. Siamo stati degli sciocchi. Abbiamo cercato di rimuovere Darwin, Huxley e Freud. Ma non era facile buttarli giù dai loro piedistalli. E allora, come idioti, abbiamo tentato di abbattere la religione. E abbiamo fatto un bell’affare: abbiamo perduto la fede e ce ne siamo andati in giro chiedendoci quale fosse lo scopo, il senso della vita. Se l’arte non era nulla più di un fremito di desiderio frustrato, se la religione non era che autoillusione, che cosa c’era di bello nella vita? La fede ci aveva sempre dato le risposte, ma con Freud e Darwin tutto è andato a finire nella spazzatura. Eravamo e siamo tuttora una razza perduta”.

Tra tutti gli episodi di incontro/scontro tra umani e alieni, narrati dall’autore che scrive come se stesse tenendo una vera e propria cronaca dettagliata della colonizzazione di Marte, l’immagine che più mi è rimasta incollata alla memoria è l’incontro tra gli ultimi due esseri rimasti sul pianeta, un uomo e una donna, tra loro un telefono che squilla. Lui corre da una casa deserta a un’altra, aspettando e sperando che il telefono squilli proprio lì e il contatto si stabilisca. Finalmente riesce a rispondere in tempo per sentire la voce dall’altro capo del filo. Il contatto è stabilito e lui fa di tutto per incontrare la donna. E poi, quando finalmente la trova…?
Che succede quando inseguiamo la nostra verità al di fuori di noi?
Mi sono chiesta leggendo le cronache e mi chiedo da una vita. E, pur chiedendomelo, pur riconoscendo il meccanismo, continuo a ricaderci, continuo a cercare, con l’unica certezza che tutto sommato quello che conta, almeno per me, qui e ora, è continuare a farlo, cercare me stessa attraverso quel filo invisibile ma indistruttibile che è la relazione con l’altro da me.
