
Cura

L’amica Marilena Votta, che per me ormai è “la galassia dei libri” mi ha consegnato una poesia che è un canto dell’essere madre e dell’essere figli. È di Paul Eluard e suona così:
“C’è una pianta che batte
alla porta della terra
ed è un figlio che batte
alla porta di sua madre
Ci sono pioggia e sole
che con quel figlio nascono
crescono con la pianta
con quel figlio fioriscono.
Odo ragionare e ridere”.
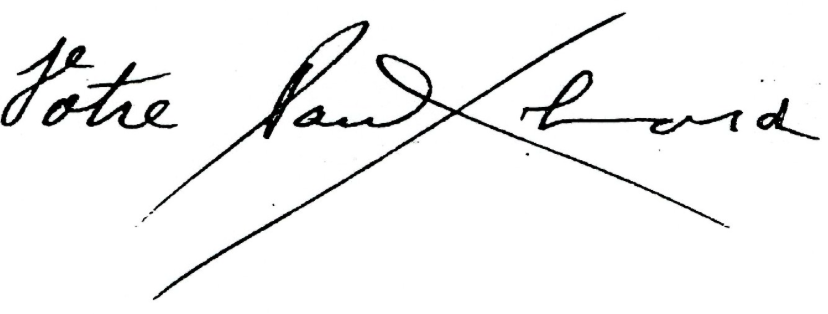
Scrivevo dell’essere madre e in realtà sono giorni che penso all’essere figlia e quindi a mia madre. Non tutti abbiamo la fortuna di generare figli ma tutti abbiamo una madre da qualche parte, se non qui e ora, dentro di noi. E in questo senso siamo tutti per forza un po’ madri, almeno di noi stesse o di noi stessi, lo siamo anche non volendo esserlo a volte, oppure lo siamo e non ce ne accorgiamo. Negli ultimi giorni questo genere di pensieri li ho filtrati attraverso la lettura di “Due secondi di troppo” (Il Seme Bianco Editore), dell’autore Andrea Mauri.
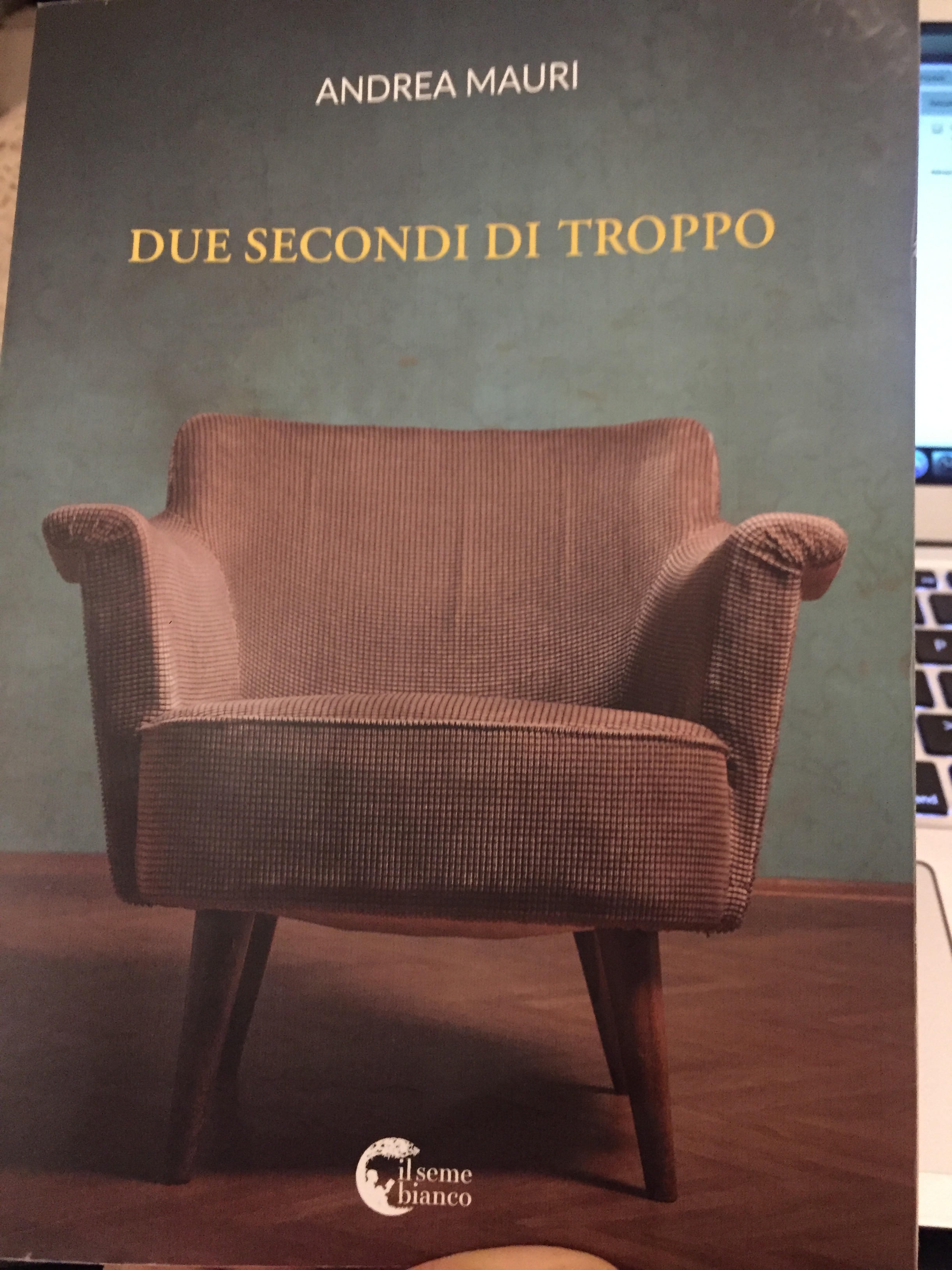
Il titolo mi faceva pensare a una storia sul tempo. E un po’ lo è. È una storia sul tempo di uno sguardo, capace di cambiare quello che osserva, come tutte le storie di trasformazione profonda. Ma è soprattutto una storia sulla cura della propria madre e la cura di se stessi, nel senso di curarsi di rendere la propria vita autentica di fronte a chi ci ha messi al mondo, la madre veggente che ci ‘legge’ e ci condiziona.
Non è facile, non è da tutti, come non è facile riuscire a non condizionare i propri figli trovandosi a essere madri. Ogni madre è un po’ una veggente nei confronti dei propri figli, e nel racconto di Mauri la madre attraversa tutta la vita con in mano un mazzo di Tarocchi. La storia si sviluppa in una clinica dove la donna affronta la vecchiaia, la malattia della perdita della memoria, mentre suo figlio l’accompagna nel ricordo, ad andarsene intera, autentica. Il rapporto tra i due si trasforma in quel mondo bianco di un luogo che potrebbe essere il palcoscenico di un teatro dove ognuno ha la sua parte da recitare. E questa metafora è resa dall’immagine memorabile del figlio che descrive un paesaggio marino a sua madre, di fronte a una vetrata che dà sul giardino della clinica, che non è un mare e non ha barche da guardare prendere il largo. Eppure i due sono dove non sono e non sono dove sono (nel senso dato da Ahmet Altan nel suo libro “Non rivedrò più il mondo” di cui ho scritto acchiappando la parola Dualità). La magia che si compie è quella di trasformare una relazione immobile, nella quale un figlio prova risentimento verso una madre troppo veggente, in un rapporto tra i due che evolve e guarisce. Attraverso la cura della propria madre quel figlio ritrova la propria autenticità e rimette al mondo la sua vita diventando, lui figlio, una madre per se stesso.

La storia è ferma in poche immagini, eppure si muove rapida, come se leggendo osservassimo quadri viventi tratti da un affresco antico. “Non ho voglia di baciarla, la saluto da lontano. Un cenno che si perde nell’oscurità dell’altro lato della stanza, quello che volge verso la notte. Mi separo da lei, lei mi separa dalla mia vita”, sono parole di una rassegnazione preludio alla morte. Eppure c’è la vita al centro dei quadri di Andrea Mauri e soprattutto c’è l’arte di uno sguardo che da osservatore diventa osservato e che dipinge la tela della nostra immaginazione con una scrittura che odora della quantità incommensurabile di profumo che un figlio sparge tra i capelli di sua madre, e fa apparire davanti ai nostri occhi un quadro di Van Gogh con quelle poche scelte parole che restituiscono tutte le pennellate del genio.
“C’è un dipinto di Van Gogh ispirato alla finestra a sbarre dell’ospedale in cui era ricoverato. Attraverso la grata di ferro riesce a riprodurre il mondo che gli si stampa sulla retina: fiori e alberi ricoperti di edera. Il suo tratto è così naturale che ci fa dimenticare di essere costretto in un luogo di sofferenza. Riesce a sublimare il dolore e a farlo scomparire nella pennellata. (…) Normalmente gli ospedali imprigionano i malati in una realtà triste, in un mondo che si alimenta della disperazione dei deboli, degli afflitti. A volte però l’isolamento forzato si infrange contro l’acume di quelli, quelli che si ribellano alla malattia, quelli che non accettano d soffrire senza uno scopo. Ecco perché nel giardino di Van Gogh la vita è troppo bella per rimanere incastrata tra le sbarre della finestra e l’ostacolo di ferro sparisce agli occhi di chi ammira l’opera”.

Come sempre quando leggo, mi trasformo anche io. E qui ho ritrovato un momento doloroso della mia vita. Mi sono rivista addormentata su una sedia accanto al letto di una corsia d’ospedale dove dormiva mia madre. Ero sia in dormiveglia che sveglia, in sospensione, mentre rivivevo quel misto di risentimento e di vergogna, di desiderio di non esserci pur provando a esserci, mentre attraversavo emozioni di ogni tipo, solo apparentemente agli antipodi: l’attaccamento, il distacco, il fastidio, la tenerezza, l’amore, l’odio, la gentilezza, la paura, il senso di inadeguatezza, quello di essere perfettamente a posto, l’ingratitudine e la gratitudine, la rabbia e la serenità…Ho anche ricordato mia madre che accudiva mia nonna (sua madre) allettata e le portava un uovo all’ostrica ogni mattina, prima che se ne andasse da questo spazio tempo.
Ho ritrovato, leggendo il libro fino alla fine, quell’insegnamento difficile ma necessario che ci incoraggia a “ripagare il debito di gratitudine nei confronti dei nostri genitori”. È un fondamento buddista ma esiste in un’infinità di sfaccettature cangianti, una per ogni cultura, come se guardassimo in un caleidoscopio le cui immagini variano, anche se la sostanza, gli specchi e le perline, è la stessa. E se saremo così fortunati da poter accompagnare nella cura i nostri genitori, nel mondo sospeso di un ospedale o dovunque ci sia concesso, tutto ci sarà perdonato e ne usciremo curati anche noi.

[…] il blu del golfo di Napoli le amiche “autrici felici”: Ester Arena del cui romanzo parlo in Prospettiva (“Il piano cartesiano dell’amore” Edito Il Seme Bianco) e Claudia Dalmastri, anche lei […]